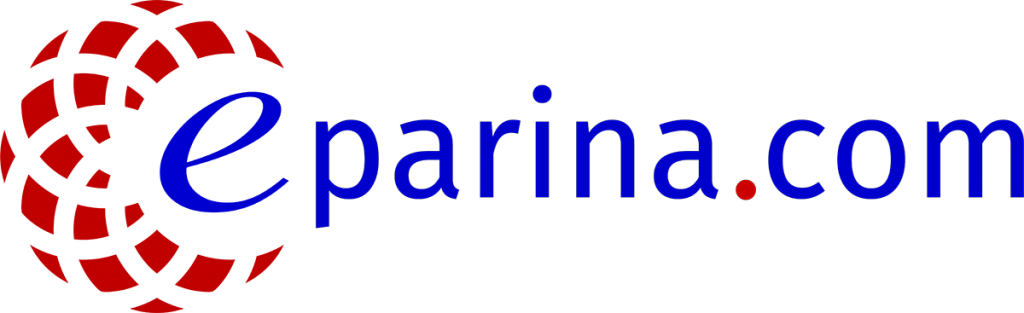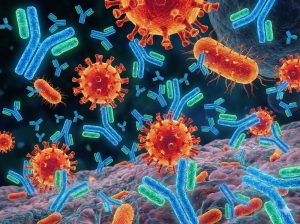L’eparina, in particolare quella a basso peso molecolare, continua a occupare un ruolo centrale nella pratica clinica quotidiana. Dalla profilassi del tromboembolismo venoso nei pazienti chirurgici e internistici, alla gestione delle complicanze trombotiche in oncologia e gravidanza, questo farmaco “storico” mantiene caratteristiche di efficacia e sicurezza difficilmente eguagliabili. Ma proprio perché si tratta di un farmaco scoperto più di cento anni fa, è lecito chiedersi quale possa essere il suo futuro. Ne abbiamo parlato con il professor Marco Marietta, Presidente della Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie anticoagulanti (FCSA) e Direttore della UOS “Malattie della Coagulazione” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

L’eparina è destinata ad essere soppiantata dagli anticoagulanti orali(DOAC) o in alcune situazioni rimane insostituibile?
L’eparina a basso peso molecolare (EPBM) rimane insostituibile per le caratteristiche della sua molecola in alcune situazioni. Innanzitutto nella profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nella chirurgia ortopedica minore (es. artroscopia di ginocchio, interventi al piede), indicata per un periodo limitato (7-14 giorni). Le EPBM, come l’enoxaparina, sono lo standard per la loro efficacia dimostrata in studi randomizzati controllati, con una riduzione del rischio di TEV sintomatico fino al 60% rispetto al placebo. I DOAC, pur efficaci in chirurgia ortopedica maggiore (es. protesi d’anca o ginocchio), mancano di dati robusti per le procedure minori, dove il rapporto rischio-beneficio è meno chiaro a causa del minor rischio trombotico assoluto e del potenziale aumento di sanguinamenti locali. La possibilità di dosaggi personalizzati e la sospensione rapida rendono l’eparina preferibile.
Un altro ambito in cui le EBPM rimangono i farmaci di riferimento è la profilassi del TEV nei pazienti internistici ospedalizzati (ad esempio per polmonite, scompenso cardiaco, sepsi). In questi casi il rischio di TEV in assenza di profilassi farmacologica è elevato, e può arrivare al 10-20%. Le EPBM sono il trattamento di scelta, come raccomandato dalle linee guida, per la loro efficacia consolidata e la possibilità di aggiustare le dosi in base al peso corporeo o alla funzione renale. Gli studi sui DOAC in questo contesto, non hanno mostrato una superiorità significativa, ma anzi un aumento del rischio di sanguinamento maggiore. Inoltre, la necessità di somministrazione orale può essere problematica in pazienti critici con disfagia o alterata motilità gastrica.
Un’altra categoria di pazienti in cui l’impiego di eparina rimane insostituibile sono i malati oncologici. Sebbene i DOAC siano ora ampiamente impiegati nei pazienti con trombosi venosa profonda raccomandati come alternativa in pazienti selezionati, il loro uso è limitato da un aumento del rischio di sanguinamento maggiore. Le EBPM offrono una maggiore flessibilità di dosaggio e sono preferite nei pazienti ad alto rischio emorragico.
Per lo stesso motivo anche in caso di pazienti piastrinopenici, l’eparina permette una gestione più sicura grazie alla possibilità di sospendere rapidamente l’anticoagulazione o di usare dosi profilattiche ridotte. I DOAC, con emivita più lunga, aumentano il rischio di accumulo e sanguinamento in questi pazienti fragili. Infine, le EBPM sono il trattamento anticoagulante di scelta in gravidanza e nel post partum, sia come profilassi che come terapia, per la loro incapacità di attraversare la barriera placentare, garantendo sicurezza fetale, e per l’assenza di secrezione significativa nel latte materno.
Inoltre, l’eparina consente aggiustamenti posologici precisi in base al peso materno, che cambia durante la gravidanza, e una gestione sicura in prossimità del parto grazie alla reversibilità con protamina, una proteina che ne neutralizza gli effetti anticoaguanti.
Quali sono le aree grigie per quanto riguarda la terapia anticoagulante con eparina? Perché persiste ancora tanta variabilità nella prescrizione?
La variabilità nelle pratiche prescrittive dell’eparina è multifattoriale. In primo luogo esiste la discrezionalità clinica. I medici, influenzati da esperienze personali, formazione e contesto lavorativo, possono adottare approcci diversi in assenza di linee guida cogenti che lasciano spazio alla flessibilità. Inoltre, molte indicazioni per l’eparina si basano su trial datati o con campioni limitati, specialmente in popolazioni specifiche (es. pazienti internistici a rischio intermedio, chirurgia minore).
Ad esempio, nella chirurgia ortopedica minore, in pazienti a basso rischio, la profilassi eparinica può essere percepita come opzionale, anche per la scarsità di studi ben condotti in quest’ambito. Sempre nel caso della chirurgia ortopedica minore, l’incidenza di TEV è così bassa che servirebbero trial con campioni di decine di migliaia di pazienti per rilevare differenze significative tra profilassi eparinica e placebo, studi logisticamente ed economicamente impraticabili. Da non trascurare poi gli aspetti medico-legali: il timore di contenziosi spinge alcuni clinici a prescrivere eparina anche in scenari a basso rischio, come forma di medicina difensiva, mentre in ambito ospedaliero le decisioni prescrittive sono influenzate dai costi e dai budget.
Quali sono gli usi meno conosciuti di eparina?
Un uso “meno noto” è il mancato utilizzo dell’eparina per la profilassi del TEV nei pazienti con tumori solidi (es. pancreas, polmone) o ematologici (es. mieloma multiplo), dove il rischio è altissimo (4-7 volte la norma). Eppure, spesso non si usa per paura di sanguinamenti o perché i medici sottovalutano il problema. Perché è importante? Il TEV è la seconda causa di morte non tumorale in oncologia. Ma i dati (es. il registro RIETE) dicono che solo il 40-50% dei pazienti a rischio riceve profilassi.
A parte il suo utilizzo come anticoagulante, è stato dimostrato che l’eparina, come glicosaminoglicano (GAG), interagisce con proteine, cellule endoteliali e mediatori infiammatori, offrendo potenziali benefici in ambiti anche non strettamente coagulativi. Questo è risultato utile in malattie infiammatorie croniche o acute, dalla colite ulcerosa, all’asma, all’artrite reumatoide.
L’eparina può ostacolare virus come SARS-CoV-2, HIV o herpes, legandosi alle loro proteine di superficie (es. spike) e impedendone l’ingresso nelle cellule. Funziona perché mima l’eparan solfato delle cellule. Le eparine modificate (es. desolfatate o “glycol-split”) agiscono sui GAG endoteliali, inibendo l’eparanasi (enzima che, degradando l’eparan solfato, favorisce l’infiammazione) e stabilizzando la barriera vascolare. In sintesi l’eparina è molto più di un anticoagulante: può salvare vite in oncologia, combattere infiammazioni e virus. Ma in questi ambiti serve ulteriore ricerca.
Quale futuro per un farmaco di origine animale, in un mondo in cui istanze religiose ed etiche possono renderne l’utilizzo più problematico?
Personalmente non ho mai incontrato resistenze da parte dei pazienti. Il tema però è di attualità, in un mondo sempre più globalizzato. Alcune ricerche esplorano la questione e ciò che emerge è la necessità di un approccio più inclusivo, a partire dal consenso informato fino alla proposta, laddove sia possibile, di terapie alternative. In contesti ospedalieri, la mancanza di trasparenza può causare ritardi terapeutici o contenziosi.
L’origine suina dell’eparina confligge con alcune credenze religiose, ma da quanto emerge dalle osservazioni disponibili, l’utilizzo del farmaco viene il più delle volte concesso poiché si tratta di un farmaco salva vita, soprattutto in emergenza o se non ci sono alternative. Attualmente esistono delle ricerche per la produzione di eparina bioingegnerizzata a partire da fermentazione microbica. Si tratta di studi pilota e di trial su modelli animali. Ci sono però delle criticità notevoli: la fermentazione produce quantità inferiori di farmaco rispetto all’estrazione animale (tonnellate/anno) e i costi restano 2-3 volte superiori. Al momento quindi ritengo che l’eparina di derivazione animale abbia davanti a sé un futuro ancora lungo.
Originator o biosimilare: ci sono ancora resistenze da parte dei clinici nel somministrare il prodotto non originale?
I biosimilari autorizzati da EMA e AIFA hanno ampiamente dimostrato equivalenza in termini di efficacia e sicurezza, offrendo ai medici un’opzione terapeutica sovrapponibile all’originator e notevolmente vantaggiosa in termini di spesa sanitaria. Tuttavia alcuni medici soprattutto in pazienti fragili come oncologici, gravide o soggetti ad alto rischio emorragico preferiscono prescrivere, senza un reale motivo, il farmaco originale. Inoltre, molti percepiscono che i dati comparativi non siano ancora sufficientemente estesi a tutti i contesti d’uso, e ciò, unito al timore di implicazioni medico-legali, favorisce una certa resistenza al passaggio dal brand al biosimilare. Infine, la spinta all’utilizzo dei biosimilari varia tra Regioni e strutture, creando disomogeneità prescrittive e la necessità di informare meglio sia gli operatori sanitari sia i pazienti sul loro reale profilo di efficacia e sicurezza.